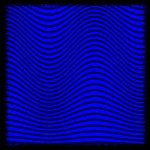|
|
FiloSTM YouTube Channel
|
|
ITA
|

|
ENG
|

|
|
NATURALISTIC ENGINEERING
|
NATURALISTIC ENGINEERING
Sorry, the page will be translated as soon as possible
Questa disciplina ingegneristica trova spazio ed applicazione nel nord Europa da qualche decennio, mentre in Italia stenta ad affermarsi, anche se il paesaggio del territorio italiano
costituisce un patrimonio nazionale fondamentale.
Il territorio italiano presenta delle criticità idrogeologiche, che meritano o meriterebbero grande attenzione con un approccio di prevenzione, che, invece, viene sovrastato da una situazione di emergenza ordinaria.
Ma, al di là di questi aspetti pragmatici importantissimi, è bene soffermarsi sui termini "paesaggio" e "territorio", non per un semplice esercizio intellettuale e linguistico, ma per comprendere in modo critico cosa significhi considerare il rapporto tra esseri umani, paesaggio e territorio.
Per territorio intendo quanto definito dal geografo francese Claude Raffestin: il territorio è l'insieme di parti correlate, in cui l'uomo interviene attraverso il processo di territorializzazione, ovvero attraverso l'occupazione di un luogo fisico, geografico, insediando attività di vario tipo.
E il territorio non è qualcosa di semplicemente geografico o cartografico, ma un insieme di elementi combinati dall' "attore sintagmatico" umano, elementi classificabili in elementi morfologico-geologici, biologici e antropologici.
In questa classificazione, emerge subito che l'elemento antropologico si distacca dagli altri elementi naturali, come se l'essere umano non facesse parte in qualche modo della Natura.
Ma così posta, come deve essere, questa diventa una questione filosofica, di teoria della conoscenza e di etica.
Infatti, dobbiamo porci il problema del diritto che l'essere umano si attribuisce nel mettersi in relazione con elementi naturali, intervendendo con modifiche degli elementi naturali stessi, fino ad arrivare allo sfruttamento intensivo del territorio per accumulare ricchezze materiali e finanziarie.
La nostra esperienza sensoriale del territorio passa attraverso il paesaggio, ovvero quello che noi osserviamo visivamente, olfattivamente, come spettatori.
Ma anche in questa "esperienza paesaggistica" iniziamo a metterci in relazione con il territorio, iniziando a comprendere in che modo gli essere umani costruiscono relazioni con elementi geomorfologici e biologici e notando in che modo gli esseri umani completano o distruggono tali elementi.
Dall'osservazione paesaggistica, da attenti osservatori, si può comprendere l'inserimento armonico o disarmonico delle attività umane in una struttura naturale esistente.
La domanda da porsi a questo punto è che cosa si deve intendere per natura e per naturalezza e in che modo le attività umane, e ancora prima il pensiero umano, si mostra naturale o innaturale.
Non provo a dare la risposta ora, in questo luogo, ma lascio in sospeso la questione.
Ora mi interessa volgere l'attenzione in modo specifico sull'ingegneria naturalistica, cercando di superare le definizioni convenzionali di ingegneria naturalistica stessa.
In sostanza l'ingegneria naturalistica non è una disciplina in sè nuova, ma è un approccio, un metodo nel pensare, nel progettare e costruire insediamenti umani in contesti naturali, ovvero idrogeologici e biologici.
In altro modo, si può dire che l'ingegneria naturalistica è un volto fondamentale della "system and safety engineering", includendo diverse ingegnerie, come l'ingegneria idraulica, l'ingegneria edile e infrastrutturale, sulle basi delle conoscenze di fisica e geologia, di biologia e di energetica.
In modo atipico, si può dire, dunque, che si vede la Natura come un sistema, anzi come il sistema, con un approccio profondamente rispettoso di equilibri naturali, biologici, che sono il fondamento della vita terrestere, anche della vita umana.
E come nell'ingegneria di sistema, anche nell'ingegneria naturalistica, occorre una visione da "homo universalis", ovvero una visione globale, completa, che consenta di coordinare i diversi aspetti nel funzionamento corretto, armonico ed equilibrato delle parti intimamente connesse di un sistema biologico.
Il territorio italiano presenta delle criticità idrogeologiche, che meritano o meriterebbero grande attenzione con un approccio di prevenzione, che, invece, viene sovrastato da una situazione di emergenza ordinaria.
Ma, al di là di questi aspetti pragmatici importantissimi, è bene soffermarsi sui termini "paesaggio" e "territorio", non per un semplice esercizio intellettuale e linguistico, ma per comprendere in modo critico cosa significhi considerare il rapporto tra esseri umani, paesaggio e territorio.
Per territorio intendo quanto definito dal geografo francese Claude Raffestin: il territorio è l'insieme di parti correlate, in cui l'uomo interviene attraverso il processo di territorializzazione, ovvero attraverso l'occupazione di un luogo fisico, geografico, insediando attività di vario tipo.
E il territorio non è qualcosa di semplicemente geografico o cartografico, ma un insieme di elementi combinati dall' "attore sintagmatico" umano, elementi classificabili in elementi morfologico-geologici, biologici e antropologici.
In questa classificazione, emerge subito che l'elemento antropologico si distacca dagli altri elementi naturali, come se l'essere umano non facesse parte in qualche modo della Natura.
Ma così posta, come deve essere, questa diventa una questione filosofica, di teoria della conoscenza e di etica.
Infatti, dobbiamo porci il problema del diritto che l'essere umano si attribuisce nel mettersi in relazione con elementi naturali, intervendendo con modifiche degli elementi naturali stessi, fino ad arrivare allo sfruttamento intensivo del territorio per accumulare ricchezze materiali e finanziarie.
La nostra esperienza sensoriale del territorio passa attraverso il paesaggio, ovvero quello che noi osserviamo visivamente, olfattivamente, come spettatori.
Ma anche in questa "esperienza paesaggistica" iniziamo a metterci in relazione con il territorio, iniziando a comprendere in che modo gli essere umani costruiscono relazioni con elementi geomorfologici e biologici e notando in che modo gli esseri umani completano o distruggono tali elementi.
Dall'osservazione paesaggistica, da attenti osservatori, si può comprendere l'inserimento armonico o disarmonico delle attività umane in una struttura naturale esistente.
La domanda da porsi a questo punto è che cosa si deve intendere per natura e per naturalezza e in che modo le attività umane, e ancora prima il pensiero umano, si mostra naturale o innaturale.
Non provo a dare la risposta ora, in questo luogo, ma lascio in sospeso la questione.
Ora mi interessa volgere l'attenzione in modo specifico sull'ingegneria naturalistica, cercando di superare le definizioni convenzionali di ingegneria naturalistica stessa.
In sostanza l'ingegneria naturalistica non è una disciplina in sè nuova, ma è un approccio, un metodo nel pensare, nel progettare e costruire insediamenti umani in contesti naturali, ovvero idrogeologici e biologici.
In altro modo, si può dire che l'ingegneria naturalistica è un volto fondamentale della "system and safety engineering", includendo diverse ingegnerie, come l'ingegneria idraulica, l'ingegneria edile e infrastrutturale, sulle basi delle conoscenze di fisica e geologia, di biologia e di energetica.
In modo atipico, si può dire, dunque, che si vede la Natura come un sistema, anzi come il sistema, con un approccio profondamente rispettoso di equilibri naturali, biologici, che sono il fondamento della vita terrestere, anche della vita umana.
E come nell'ingegneria di sistema, anche nell'ingegneria naturalistica, occorre una visione da "homo universalis", ovvero una visione globale, completa, che consenta di coordinare i diversi aspetti nel funzionamento corretto, armonico ed equilibrato delle parti intimamente connesse di un sistema biologico.
Geologia: suolo e acqua
Il suolo e l'acqua costituiscono elementi naturali essenziali per la vita del pianeta Terra, per tutte le forme di vita.
Per suolo bisogna intendere lo strato superficiale della crosta terrestre, adatta alla coltivazione ed alla vita vegetale.
E l'acqua modella le forme vegetali, che formano il paesaggio naturale: dal punto di vista chimico-fisico l'acqua nasconde ancora oggi dei misteri da rivelare.
La vita ottima del suolo dipende dagli strati profondi, associati anche alle falde acquifere.
In sostanza, c'è una forte e chiara interconnessione idrogeologica tra gli strati che compongono la crosta terrestre, così come esiste una forte dipendenza tra mondo vegetale e mondo minerale.
Per suolo bisogna intendere lo strato superficiale della crosta terrestre, adatta alla coltivazione ed alla vita vegetale.
E l'acqua modella le forme vegetali, che formano il paesaggio naturale: dal punto di vista chimico-fisico l'acqua nasconde ancora oggi dei misteri da rivelare.
La vita ottima del suolo dipende dagli strati profondi, associati anche alle falde acquifere.
In sostanza, c'è una forte e chiara interconnessione idrogeologica tra gli strati che compongono la crosta terrestre, così come esiste una forte dipendenza tra mondo vegetale e mondo minerale.
Idromorfologia territoriale
L'acqua con i processi di erosione e di sedimentazione modella la superficie terrestre, creando un'impronta chiara e distintiva nel territorio.
Nello sviluppo dei corsi d'acqua è fondamentale distinguere in 4 aree o unità principali: l'unità montuosa, l'unità collinare, l'unità di pianura prossimale e l'unità di pianura costiera.
Queste 4 aree hanno criticità differenti affrontabili con i metodi e le tecniche della geomorfologia, che non si limita a studiare le forme, ma soprattutto a studiare e comprendere i processi legati alla morfologia fluviale, facendo particolare attenzione alle scale temporali e ai disturbi apportati ai processi naturali da parte di attività antropiche.
Nello sviluppo dei corsi d'acqua è fondamentale distinguere in 4 aree o unità principali: l'unità montuosa, l'unità collinare, l'unità di pianura prossimale e l'unità di pianura costiera.
Queste 4 aree hanno criticità differenti affrontabili con i metodi e le tecniche della geomorfologia, che non si limita a studiare le forme, ma soprattutto a studiare e comprendere i processi legati alla morfologia fluviale, facendo particolare attenzione alle scale temporali e ai disturbi apportati ai processi naturali da parte di attività antropiche.
Recupero e riassetto idrogeologico
I metodi della geomorfologia fluviale possono essere interessanti per procedere in modo attivo con un recupero ed un riassetto idrogeologico, che proceda sia attraverso un approccio
qualitativo sia soprattutto attraverso un approccio quantitativo, attraverso misurazioni ed osservazioni sperimentali di diverso tipo (fotogrammetria, sistemi GPS, etc.).
In questo modo si deve giungere ad una modellazione accurata dei sistemi fluviali con diverse scale spazio-temporali, in particolare bisogna porre particolare attenzione ai processi di erosione di sponda, percepiti sistematicamente come un fenomeno da evitare. Questo è comprensibile e doveroso in territori fortemente antropizzati e urbanizzati, ma non ha ragione d'essere in tratti fluviali non urbanizzati.
Non bisogna dimenticare infatti che l'habitat naturale è popolato non solo da esseri umani, ma anche da altre specie animali oltre che da piante, in simbiosi con i corsi d'acqua.
In questo modo si deve giungere ad una modellazione accurata dei sistemi fluviali con diverse scale spazio-temporali, in particolare bisogna porre particolare attenzione ai processi di erosione di sponda, percepiti sistematicamente come un fenomeno da evitare. Questo è comprensibile e doveroso in territori fortemente antropizzati e urbanizzati, ma non ha ragione d'essere in tratti fluviali non urbanizzati.
Non bisogna dimenticare infatti che l'habitat naturale è popolato non solo da esseri umani, ma anche da altre specie animali oltre che da piante, in simbiosi con i corsi d'acqua.
Aria, sole e biologia
Seguendo la composizione degli elementi essenziali del pianeta Terra, non possiamo dimenticare l'aria e l'energia solare.
La vita terrestre si basa essenzialmente sull'energia proveniente dal sole, a partire dalla fotosintesi clorofilliana vegetale.
Le stesse fonti energetiche da combustibili fossili derivano in modo indiretto dal sole, insieme alle trasformazioni geologiche, che coinvolgono il pianeta da milioni di anni.
E seguendo la vita vegetale, scopriamo che oltre all'energia solare, si ha necessità di aria, con i relativi gas componenti.
La vita terrestre si basa essenzialmente sull'energia proveniente dal sole, a partire dalla fotosintesi clorofilliana vegetale.
Le stesse fonti energetiche da combustibili fossili derivano in modo indiretto dal sole, insieme alle trasformazioni geologiche, che coinvolgono il pianeta da milioni di anni.
E seguendo la vita vegetale, scopriamo che oltre all'energia solare, si ha necessità di aria, con i relativi gas componenti.
Le forme di vita: regno animale e regno vegetale
Seguendo la via tracciata dalle forme di vita planetarie, dobbiamo mettere in relazione il mondo vegetale con il mondo animale.
Ma tale distinzione può risultare eccessivamente scolastica e didattica: è bene vedere in modo olistico le relazioni tra mondo chimico-fisico inorganico e mondo chimico-fisico organico, rivisitando il concetto stesso di vita e di diverse forme di vita.
In questo senso, si riesce ad avere una visione ecologica, che possa partire essenzialmente dalla mente umana, in un approccio armonico e rispettoso degli equlibri biologici planetari.
In questo modo, sto anticipando un approccio tipico dell'ecologia, che non rappresenta altro che un approccio olistico nel comprendere le relazioni tra le diverse forme di vita planetarie.
Seguendo questo approccio, è rilevante la figura di Gregory Bateson, biologo, scienziato noto per il libro "Verso un ecologia della mente", fondamentale anche per lo sviluppo della cibernetica, insieme a Norbert Wiener.
Ma tale tema verrà ripreso nella pagina relativa alla biologia e all'ecologia.
Una visione critica dell'antropizzazione dell'ambiente naturale
In queste considerazioni sul regno animale e sul regno vegetale, sul territorio e sul paesaggio, l'essere umano che ruolo gioca e ha giocato?
Potrebbe apparire che l'essere umano si sia quasi estraniato dagli equlibri fisico-biologici, come se esso stesso non appartenesse a questi equlibri.
Ed osserviamo nel paesaggio e nel territorio come l'essere umano si sia inserito, spesso con devastazioni o con squilibri evidenti, dettati da necessità iperenergivore e da strategie non sostenibili iperproduttive.
In queste considerazioni ho introdotto il termine "ambiente", dando il significato più intuitivo ed esteso possibile, dopo aver introdotto già i termini paesaggio e territorio.
E' importante comprendersi sui termini utilizzati, ma senza esagerare con i formalismi e le definizioni forzate, cercando di non perdere di vista la sostanza delle cose.
Seguendo la via tracciata dalle forme di vita planetarie, dobbiamo mettere in relazione il mondo vegetale con il mondo animale.
Ma tale distinzione può risultare eccessivamente scolastica e didattica: è bene vedere in modo olistico le relazioni tra mondo chimico-fisico inorganico e mondo chimico-fisico organico, rivisitando il concetto stesso di vita e di diverse forme di vita.
In questo senso, si riesce ad avere una visione ecologica, che possa partire essenzialmente dalla mente umana, in un approccio armonico e rispettoso degli equlibri biologici planetari.
In questo modo, sto anticipando un approccio tipico dell'ecologia, che non rappresenta altro che un approccio olistico nel comprendere le relazioni tra le diverse forme di vita planetarie.
Seguendo questo approccio, è rilevante la figura di Gregory Bateson, biologo, scienziato noto per il libro "Verso un ecologia della mente", fondamentale anche per lo sviluppo della cibernetica, insieme a Norbert Wiener.
Ma tale tema verrà ripreso nella pagina relativa alla biologia e all'ecologia.
Una visione critica dell'antropizzazione dell'ambiente naturale
In queste considerazioni sul regno animale e sul regno vegetale, sul territorio e sul paesaggio, l'essere umano che ruolo gioca e ha giocato?
Potrebbe apparire che l'essere umano si sia quasi estraniato dagli equlibri fisico-biologici, come se esso stesso non appartenesse a questi equlibri.
Ed osserviamo nel paesaggio e nel territorio come l'essere umano si sia inserito, spesso con devastazioni o con squilibri evidenti, dettati da necessità iperenergivore e da strategie non sostenibili iperproduttive.
In queste considerazioni ho introdotto il termine "ambiente", dando il significato più intuitivo ed esteso possibile, dopo aver introdotto già i termini paesaggio e territorio.
E' importante comprendersi sui termini utilizzati, ma senza esagerare con i formalismi e le definizioni forzate, cercando di non perdere di vista la sostanza delle cose.
Attività antropiche e sostenibilità ambientale
E stando semplicemente attenti alla sostanza delle cose, per intendersi sul concetto di ambiente, può essere sufficiente considerare quella che io chiamo la "stratificazione ambientale".
Infatti oltre all'ambiente naturale, possiamo considerare, per esempio, l'ambiente culturale e l'ambiente sociale. Così, da questa semplice elencazione possiamo comprendere che per ambiente possiamo considerare il contesto, in cui avvengono i fenomeni.
L'ambiente naturale costituisce il substrato essenziale, su cui si appoggiano tutte le altre forme di ambiente, come l'ambiente sociale e l'ambiente culturale.
E concentrando l'attenzione sull'ambiente naturale, dobbiamo porre particolare attenzione all'impatto ambientale, come estensione del concetto di sicurezza.
Nel fare questo, dobbiamo estendere i confini spaziali e temporali: questo significa che attività antropiche di uno specifico territorio possono incidere significativamente sui territori circostanti, anche geograficamente distanti; allo stesso modo, dobbiamo estendere i confini temporali, per comprendere gli effetti nocici dell'inquinamento ambientale sulle generazioni future.
Dunque, bisogna pensare in termini di sicurezza ambientale in tutte le attività antropiche, per conservare equilibri biologici fondamentali e per preservare la salute, l'integrità e l'equlibrio psicofisico di ciascun essere umano.
Questo presuppone una profonda conoscenza fisica e biologica e capacità organizzative notevoli, che possano condurre ad una corretta programmazione e prevenzione, evitando di vivere in uno stato di emergenza perenne, cornica.
Infatti oltre all'ambiente naturale, possiamo considerare, per esempio, l'ambiente culturale e l'ambiente sociale. Così, da questa semplice elencazione possiamo comprendere che per ambiente possiamo considerare il contesto, in cui avvengono i fenomeni.
L'ambiente naturale costituisce il substrato essenziale, su cui si appoggiano tutte le altre forme di ambiente, come l'ambiente sociale e l'ambiente culturale.
E concentrando l'attenzione sull'ambiente naturale, dobbiamo porre particolare attenzione all'impatto ambientale, come estensione del concetto di sicurezza.
Nel fare questo, dobbiamo estendere i confini spaziali e temporali: questo significa che attività antropiche di uno specifico territorio possono incidere significativamente sui territori circostanti, anche geograficamente distanti; allo stesso modo, dobbiamo estendere i confini temporali, per comprendere gli effetti nocici dell'inquinamento ambientale sulle generazioni future.
Dunque, bisogna pensare in termini di sicurezza ambientale in tutte le attività antropiche, per conservare equilibri biologici fondamentali e per preservare la salute, l'integrità e l'equlibrio psicofisico di ciascun essere umano.
Questo presuppone una profonda conoscenza fisica e biologica e capacità organizzative notevoli, che possano condurre ad una corretta programmazione e prevenzione, evitando di vivere in uno stato di emergenza perenne, cornica.